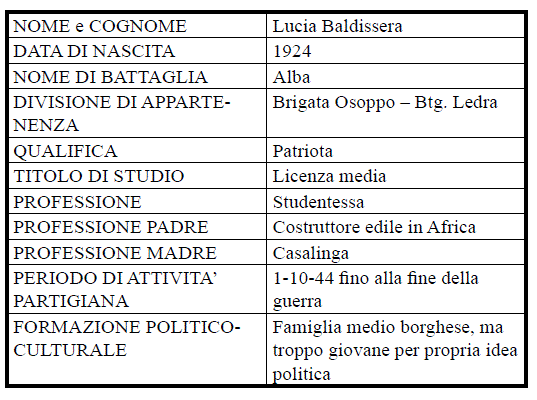Sono nata nel 1924 e quindi allo scoppio della guerra ero molto giovane ed ero una studentessa. Avevo finito le scuole medie e siccome ero molto brava in disegno, mi mandarono a fare il liceo artistico a Venezia, ma riuscii a fare solo il biennio perché poi scoppiò la guerra e io dovetti tornare a casa. Con la mia famiglia abitavo a Udine, ma siccome la città era spesso bombardata, ci trasferimmo a Gemona, nella casa dei miei nonni. Quando bombardarono anche Gemona andammo a Montenars, dove avevamo una casa che abitavamo solo d’estate.
Durante i bombardamenti di Gemona io non mi muovevo mai di casa, non scappavo come si faceva sempre, per andare nel rifugio in una grotta nella montagna.
L’unica volta che sono andata al ricovero, di notte, durante un bombardamento, quando sono tornata ho trovato il muro sopra il mio letto. Dovevo andare quindi a Montenars ogni sera: non avevo più la casa!
Tra Gemona e Montenars ci sono 7 km e mezzo di stradine di montagna e io tutti i giorni scendevo da Montenars a Gemona e poi tornavo su a dormire.
[…] Così quando siamo tornati a casa siamo stati un po’ a Udine, ma poi ci hanno bombardato la casa. Noi eravamo in tanti: mio padre, mia madre e cinque fratelli.
Quella volta la cosa per la quale ho pianto più di tutto è stato perchè ho perso tutti i miei libri: io andavo matta per la lettura e avevo delle collane intere, ma è stato tutto sepolto dalle macerie. Avevo la raccolta completa di due o tre autrici che mi piacevano molto, ma purtroppo…
Mio padre comunque è rimasto, per fortuna, in Africa tutto il tempo della guerra, mio fratello, invece, che aveva appena 23 anni ed era a Gorizia a scuola, è stato preso e mandato in Russia e si è fatto tutta la campagna di Russia e quando è tornato non aveva più i piedi.
Quando a mio papà dicevano “dio, che coraggio ha tua figlia!” lui rispondeva: “Quello non è coraggio, è incoscienza”, ed era vero, aveva ragione lui.
Io ero una di quelle persone che si entusiasmano facilmente e in quegli anni era il caso di entusiasmarsi, anche perché o non ti interessava niente o ti entusiasmavi per qualcosa.
Siccome ero studentessa e non lavoravo, i tedeschi avevano stabilito che tutti quelli di una età compresa tra i 14 anni ed i 60 dovevano lavorare, e così mi hanno precettata alla Todt.
Mi avevano messa in degli uffici che non erano uffici veri e propri, ma erano dei vagoni di treno adibiti ad uffici e io dovevo compilare le bollette per ritirare l’esplosivo.
Così io facevo quattro bollette per i tedeschi e una la nascondevo nella manica e così via tutta la giornata. Quelle che avevo nascosto le davo poi a mio fratello, che le portava ai partigiani.
Ero proprio incosciente perché se mi prendevano mi mandavano dritta in Germania: ma come si fa a rubare le bollette per prendere l’esplosivo per far saltare i binari dei treni dei tedeschi con il loro stesso esplosivo! Ma non ci pensavo!
I tedeschi si devono essere accorti di questo, però non sapevano bene chi poteva essere la traditrice e così ci hanno prese tutte e mandate “cun pale e picon” sul Tagliamento a costruire la strada. Sono stata un po’ di mesi lì: ci portavano la mattina con il camion, ci davano da mangiare e poi ci riportavano a casa la sera.
Ma anche lì bisognava vedere che lavoro! Eravamo tutti in fila sul greto del fiume e facevamo di tutto per lavorare il meno possibile: uno prendeva un sasso e lo passava a quell’altro, il secondo passava lo stesso sasso un po’ più in su e così via per tutta la fila, per tutto il giorno. Ma fare un lavoro del genere sul greto di un fiume vuol dire non lavorare per niente.
Anche quelli che ci controllavano poi non erano tedeschi, ma austriaci ed erano giovani anche loro e forse più di tanto non gli interessava perchè ci hanno sempre lasciato fare senza dire niente: o non guardavano o non sapevano o erano abbastanza d’accordo con noi.
Poi quando arrivava “Pippo”, che era un aeroplanino piccolo che bombardava o mitragliava, e lo si sentiva, tutti sparivano e si arrivava fino a Ospedaletto di corsa.
Poi c’è stata una volta che ho rischiato veramente tanto, ho rischiato di andare in Germania. Una mattina mi stavo preparando per andare sul Tagliamento e sulla strada mi hanno fermato un gruppetto di ragazze. Siccome sapevano che facevo qualcosa per i partigiani, anche perché le voci girano in paese e forse mi consideravano anche un po’ matta, mi hanno detto che durante la notte avevano cercato di uccidere due partigiani, ma uno non era ancora morto. Io ho detto loro di sparire anche perché, siccome avevano già padri, fratelli o qualcun altro in montagna con i partigiani ed erano tenute d’occhio, era meglio che non rischiassero. Io invece non ero segnalata e così sono andata a vedere di questi due. Uno era morto, ma l’altro ancora respirava. Bisognava vedere la scena: avevano cercato di strozzarli con il fil di ferro, ma uno non era morto anzi, ancora respirava.
L’abbiamo preso e messo in una baracchetta che era lì, una di quelle baracche per i pastori dove c’era solo una panca e uno “spolert” e così ho cercato di fare qualcosa per lui, ma l’unica cosa che avevo per curarlo era una bottiglia di grappa.
Naturalmente era tenuto d’occhio e così, dopo poco tempo che ero lì, è arrivata una pattuglia di fascisti: il capo era abbastanza anziano ma gli altri cinque erano ragazzini di 14 o 15 anni tutti quanti armati fino ai denti con i fucili più grandi di loro.
Come sono entrati hanno cominciato a dirmi che dovevo assolutamente andare via e che dovevano finire di ammazzarlo, ma io, che non avevo mai visto una scena del genere, già ero sconvolta e poi a vedere questi che entrano così e poi così giovani, mi è venuto su un nervoso che ho cominciato a urlargli contro e a dirgli di tutto: che dovevano vergognarsi, di andare via loro, di non accanirsi contro il poveretto che già era in fin di vita. Siamo stati lì a discutere più di un’ora: loro con i fucili spianati e io che gli urlavo contro e li insultavo.
L’anziano che li comandava, che era un povero diavolo, non aveva nessuna voglia di sparare e di mettersi in pasticci più grandi di lui, ma non poteva neanche farsi vedere debole davanti ai ragazzini e così discuteva con me, ma alla fine mi ha lasciata andare.
Nel frattempo era arrivato un medico, ma il poveretto era già morto e io ho potuto ripensare alla scena che avevo appena vissuto e mi è venuta un po’ di paura perché se fossero stati un po’ più coraggiosi o un po’ più svegli, avrebbero potuto spararmi tutti insieme sull’istante o mandarmi in Germania.
Dopo quel fatto erano tutti a dirmi “nasconditi, scappa, ti mandiamo in montagna” ma io non ho voluto anche perché, visto che lavoravo alla Todt, si sarebbero accorti se io non fossi più andata e se venivano a cercarmi e non mi trovavano se la sarebbero presa con la mia famiglia.
E così ho cominciato. Non è stata una cosa preventivata, non ci siamo messi d’accordo, ma tutti i nostri amici o quelli che conoscevamo erano contrari ai tedeschi e si sentiva nell’aria che avevano organizzato qualcosa. Non si sapeva né chi né come, ma non potevi stare con le mani in mano soprattutto quando vedevi quei treni, fermi in stazione a Gemona, chiusi e sprangati con dentro la gente che moriva di fame e di sete pronti per andare in Germania.
Non potevi restare lì a guardare senza fare niente, specialmente perché eri giovane, altrimenti ti saresti sentita quasi complice. E così, per questi poveri disgraziati andavi giù con le pompe e cercavi di buttare l’acqua dentro ai finestrini, che non erano neanche finestrini ma grate. C’erano le donne che lavoravano tutta la notte a fare le polente per buttargliele dentro e non riuscivi perché i vagoni erano sigillati e magari potevi prendere anche un sacco di botte dai tedeschi che per fortuna non sparavano, ma che però colpivano volentieri con il calcio del fucile.
Erano quelle cose che uno faceva perché si sentiva di fare, perché non poteva stare fermo a guardare quello che succedeva, era una cosa d’istinto: è come se vedi uno che cade per strada e ti viene di dargli una mano e tirarlo su. Era la stessa cosa e in più, essendo giovani, anche se sapevamo che era pericoloso, lo facevamo lo stesso.
Tutto questo è successo dopo l’8 settembre, ma prima cosa pensava del fascismo?
Bé, si può dire che io prima ero fascista, non nel senso che approvavo ed ero d’accordo con gli ideali che esso proponeva, ma io sono nata nel ‘24 e quindi ho sempre e solo visto il fascismo. Poi siccome ero a scuola, e per andarci bisognava essere iscritti al partito, avevo la tessera come tutti e siccome io ero brava in ginnastica stavo nella squadra della scuola e mi portavano in giro a fare le gare… sono andata anche a Firenze: per me era bellissimo, mi divertivo molto!
Io non sapevo niente né di politica né di altro e per quello che interessava a me andava bene così. A casa mia poi non si sono mai interessati più di tanto, anche perché mio padre era lontano e di famiglia siamo sempre stati bene, non abbiamo mai sofferto la fame, neanche in periodo di guerra.
Poi invece quando ho cominciato a vedere tutti quei treni o tutti quei giovani mandati in guerra in Russia o chissà dove e ci si è accorti, allora ho cambiato idea ed è stata tutta un’altra cosa.
Poi appena finita la guerra, quando i tedeschi se ne sono andati, c’erano tutti i partigiani che scendevano dalla montagna ed alcuni erano veramente malati ed io insieme con alcuni medici dell’ospedale di Gemona, cercavo di curarli come potevo nell’ambulatorio della caserma.
Io, ovviamente, facevo solo delle medicazioni. Si cercava di curarli come si poteva anche perché venivano giù pieni di infezioni perché magari erano stati feriti e curati male o per niente. Avevano mangiato solo polenta per mesi e mesi e forse neanche quella.
Il dopoguerra era solo un dare una mano a chi aveva bisogno: era tutto lì.
Lei lavorava per i partigiani della Osoppo, come mai ha fatto questa scelta?
Non è stata una scelta è che quelli che conoscevo io erano della Osoppo è stato così.
Era tutto un giro di conoscenze, di amici. Ci si conosceva e ci si fidava e magari ogni tanto ti chiedevano se riuscivi a prendere una cosa o l’altra.
C’era tutto un giro di passaparola, specialmente tra le ragazze. Ci si avvisava se magari passava un treno o c’era una pattuglia o bisognava avvertire quelli che erano in montagna, ma non si chiedeva mai niente, né da chi era partita la notizia, né nient’altro.
Come è proseguita la sua vita dopo la guerra?
Mi sono sposata, sono andata in Australia quattro anni, ho avuto quattro figli e ho badato a loro.
Mio marito era radiotelegrafista marittimo ed era stato preso prigioniero e si è fatto due anni e mezzo di prigionia in Olanda. Quando è tornato a casa l’ho conosciuto perché i suoi genitori, visto che gli avevano sequestrato la casa a Opicina, erano venuti a vivere a Montenars.
Siccome lui era profugo giuliano, c’era la possibilità di andare in Australia gratis: ti portavano là, ti davano la casa e un lavoro.
[…] Come ha avuto la qualifica di patriota? L’ha richiesta Lei?
No, io non ho fatto niente, anche perché nei paesi ci si conosce tutti e tutti sanno cosa hai fatto e come, quindi hanno fatto tutto loro, sono loro che mi hanno contattato. Io mi sono solo iscritta all’ANPI e basta.
Lucia Baldissera, Intervista del 9 settembre 2004
Eleonora Buzziolo, Partigiane in Friuli: storia e memoria, Tesi di laurea, Università degli Studi di Trieste, Anno Accademico 2003-2004