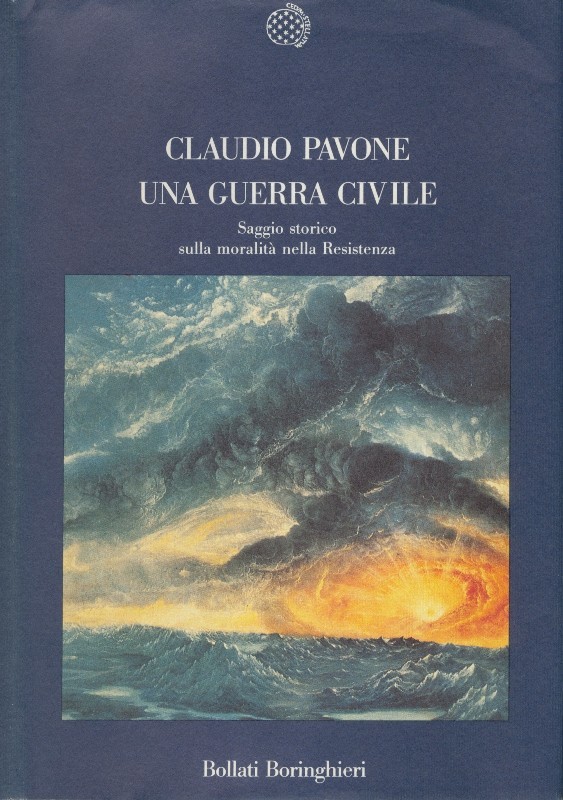
[…] Il percorso da te delineato rende più chiari alcuni aspetti relativi alle fonti da te utilizzate e alla metodologia. Per quanto riguarda in particolare l’uso delle fonti, nel libro si nota un netto privilegiamento di quelle cosiddette “basse”. Sembra che tu sia interessato più al punto di vista dei singoli militanti di base che a quello degli apparati di vertice dei partiti.
Anch’io, nella prefazione, dichiaro questo interesse per le fonti “basse”. In effetti, mi è stato poi fatto notare, e credo che sia giusto, che in realtà quelle che utilizzo in prevalenza non sono fonti “basse”, più correttamente le potremmo definire “medie”. Il motivo è che è difficile far parlare i “bassi”, gli umili, quelli che non scrivono. Biso- gnerebbe chiederlo a Cesare Bermani, che ha sempre avuto questo rovello di fare parlare i “bassi”. Sarebbero serviti dei sunti orali, però la gente in gran parte era morta. Insomma, nel mio libro di fonti “basse” nel senso vero e proprio ce ne sono poche. Ci sono le fonti medie e medio-basse, intendendo per queste ultime un livello già abbastanza politicizzato, persone che erano perlomeno militanti nelle formazioni partigiane o che comunque avevano preso posizione. Vorrei ricordare anche che non avrei potuto scrivere questo libro senza l’enorme lavoro di scavo e di accumulo di materiali compiuto nel corso degli anni dagli Istituti storici della Resistenza che fanno capo all’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. Questo lavoro era rimasto in un certo senso circoscritto a un gruppo ristretto di persone, sia storici di professione – soprattutto quelli che si occupano di storia contemporanea – sia militanti e reduci di associazioni partigiane, però stentava ad uscire allo scoperto e a raggiungere un pubblico più vasto. Per scrivere il libro mi sono servito moltissimo degli Archivi degli Istituti, e dei contributi ormai numerosi pubblicati da studiosi che operano in collegamento con essi.
Sempre riguardo le fonti, il lettore resta colpito dalla loro vastità e varietà. La tipologia è la più diversa, vengono utilizzati i documenti ufficiali delle bande partigiane, dei CLN, dei partiti, i giornali, la memorialistica, le fonti orali, le lettere dei caduti della Resistenza e anche della Repubblica Sociale Italiana. Vi è, infine, un uso interessante delle fonti letterarie, con una particolare predilezione per Beppe Fenoglio e Italo Calvino. Quali sono i criteri che hai adottato per queste fonti letterarie?
C’è innanzitutto una questione di simpatia, di preferenza. Quando si scelgono le fonti si utilizza anche questo criterio. Si tratta di preferenze non del tutto cervellotiche in rapporto all’uso che ne volevo fare. Il confine tra memorialistica e letteratura, tra narrazione biografica e invenzione letteraria, è molto sfumato sul terreno resistenziale, perché molti dei libri più belli, a cominciare da quelli di Fenoglio e Calvino, sono in fondo l’elaborazione in forma letteraria delle esperienze personali. Ovviamente questi romanzi non vanno presi come fonti di fatti, può essere anche tutto inventato, anche se poi non è così perché sappiamo che sia Fenoglio che Calvino sono stati partigiani, in situazioni diverse. Il fatto importante comunque è che qualche volta loro riescono ad esprimere alcune cose che in altri tipi di fonti si esprimono peggio. Essi sembrano collocarsi su una sorta di confine fra la memorialistica ed una elaborazione più raffinata della stessa memoria. Per questo tentativo di ricostruire una realtà, un costume il più possibile diffuso, Fenoglio e Calvino mi sono sembrati i più rappresentativi: perché riescono a far parlare il “basso” in maniera più spontanea di quanto, ad esempio, non faccia Elio Vittorini nel suo Uomini e no, che sempre mi è sembrato artificioso (ma non pretendo che la mia antipatia per Vittorini sia un giudizio letterario). Così ho scartato anche un libro che quando apparve ebbe un grande successo, L’Agnese va a morire di Renata Viganò, che a me non piaceva perchè mi sembrava che ricadesse nella maniera, fosse un po’ retorico.
Un altro scrittore che citi spesso è Luigi Meneghello. Vale lo stesso discorso?
Vale lo stesso discorso anche se, a mio avviso, Meneghello non è all’altezza di Calvino e Fenoglio. È molto bravo, disinvolto, e fa capire molte cose. Indubbiamente, sia I piccoli maestri che l’ultimo, Bausète!, sono libri importanti. Però è un po’ troppo letterato, si compiace troppo di una scrittura ricercata. È utilizzabile ma, insomma, è un letterato, un professore, mentre Calvino e Fenoglio non erano professori. Essere professore comporta sempre dei danni. Piuttosto, vale la pena di parlare dei romanzi fascisti. Sono stato rimproverato di avere utilizzato quasi solo Carlo Mazzantini, autore di A cercar la bella morte. Questo, debbo dire, per mia negligenza perché ho letto solo dopo Il tiro al piccione di Rimanelli, che è stato ripubblicato di recente. Rimanelli, dopo la fine della guerra, è emigrato negli Stati Uniti, dove ancora vive. Si è pentito alla fine, però dà un’idea forse anche più schietta rispetto a Mazzantini che è un falso pentito. Mazzantini è uno che adesso, a distanza di tempo, cerca di ricostruire un senso al suo essere stato repubblichino. Se avessi conosciuto il libro di Rimanelli, lo avrei utilizzato, anche se non avrebbe cambiato molto. Però è forse l’unico altro autore di parte fascista, accanto a Mazzantini, che varrebbe la pena di leggere.
Il tuo libro ha avuto un notevole successo, tanto più clamoroso se si pensa alle sue dimensioni e all’argomento, che sembravano destinarlo quasi solo a un pubblico di specialisti, di storici di professione. Ti aspettavi un tale successo, sia di vendite che di recensioni e di dibattito?
Francamente no, non me lo aspettavo, e credo che non se lo aspettasse nemmeno l’editore Giulio Bollati, anche se con indubbia capacità professionale aveva capito che poteva essere una cosa interessante. Infatti mi raccontava che in casa editrice quando videro questo malloppo si spaventarono, ci fu un momento di sgomento, poi però intuirono che la cosa poteva andare. L’editore ci si è dedicato molto, l’ha lanciato molto bene, ha fatto la presentazione, ha utilizzato la stampa, i mass-media. Se fosse stato un editore minore, di provincia, con una pessima distribuzione, le cose sarebbero andate diversamente.
[…] Tu stesso hai appena sostenuto che nella Resistenza c’è stata anche molta violenza arbitraria. Nel dopoguerra alcune azioni dei GAP (Gruppi d’azione patriottica) sono state oggetto di critica e di polemiche, perché molti le hanno ritenute discutibili e sbagliate. Gli episodi su cui in particolare si discute sono l’attentato di Via Rasella a Roma, che comportò poi la rappresaglia nazista delle Fosse Ardeatine, e l’uccisione di Giovanni Gentile, avvenuta a Firenze nell’aprile 1944. Quali sono in proposito le tue opinioni?
Nel libro esamino direttamente il caso Gentile. Per esprimermi con una formula sintetica, secondo me l’uccisione di Gentile è un atto di guerra. Non tutti i resistenti sono stati d’accordo, soprattutto gli azionisti fiorentini hanno condannato l’episodio. Però gli azionisti torinesi, ad esempio, si sono espressi a favore. Carlo Dionisotti scrisse un articolo nei «Nuovi quaderni di Giustizia e Libertà» in cui giustificava pienamente la cosa. Anche Eugenio Curiel, sulla rivista comunista «La nostra lotta», approvò. Ne ho parlato di recente con Franco Venturi ed è tuttora d’accordo sul fatto che hanno fatto bene ad ucciderlo, eppure non è un sanguinario. La guerra civile è anche questo. Io ho avuto una volta una discussione con Luigi Ferrajoli, grande giurista garantista, e lui sosteneva che Gentile aveva commesso solo un reato d’opinione e quindi non andava colpito. Ferrajoli si è impegnato molto per il caso 7 aprile, e lui ha sempre sostenuto la necessità di distinguere il reato d’opinione dalle azioni concrete violente. Io posso condividere il fatto che non fosse giusto fucilare o tenere in carcere Toni Negri, anche se ha scritto delle balle, però il caso di Gentile è diverso, proprio perché è un atto di guerra. So che su questo punto non ci può essere pieno accordo.
Vuoi dire che secondo te era lecito uccidere chiunque si schierasse dalla parte dei fascisti, indipendentemente dai suoi comportamenti concreti, cioè dalla partecipazione a scontri armati, a rastrellamenti, a torture?
Durante la guerra civile Mussolini forse non ha sparato neanche un colpo di cerbottana, però le sue responsabilità personali per quanto è successo sono evidentemente enormi. Non conta il fatto di non aver commesso nessun atto di violenza personalmente, in un caso del genere. Gentile era troppo importante, era troppo un uomo di punta della cultura italiana e del fascismo. Aveva affermato che i partigiani andavano sterminati perché erano nemici della patria, poi aveva accettato la presidenza dell’Accademia d’Italia quando gli altri si squagliavano non foss’altro che per buon senso. Era uno che si era schierato in maniera precisa scrivendo sui giornali, e in quei frangenti un propagandista dei giornali è pienamente responsabile come chi spara. In realtà, se ne parla tanto perché è stato ammazzato un filosofo, se avessero ammazzato un usciere nessuno se ne sarebbe occupato. C’è questa idea del grande intellettuale che deve essere garantito a priori qualunque cosa faccia o dica. Questo non è possibile: tutti pagano, paghi anche lui. Mi sembra molto più serio il caso delle tantissime vittime civili morte durante la guerra e che in genere erano persone ben più estranee di Gentile rispetto a ciò che stava accadendo. Pensiamo alle vittime dei bombardamenti aerei, per esempio il famoso bombardamento su Dresda, alla fine della guerra, che ha fatto tante vittime quante Hiroshima, completamente inutile.
E per quanto riguarda l’attentato di via Rasella? È stato fatto notare che l’attentato venne compiuto contro soldati di una certa età, adatti esclusivamente a compiti di retrovia. E si sapeva che i tedeschi avevano minacciato rappresaglie molto dure.
Il fatto è che erano altoatesini, infatti sono tutti seppelliti a Bolzano. Durante la Resistenza talvolta veniva fatta una distinzione a favore degli austriaci, perché si supponeva, molto generosamente, che fossero delle vittime. Capisco che l’attentato di via Rasella possa far pensare, e che ci possano essere dubbi sulla sua opportunità. Ricordo però che «L’Osservatore Romano» uscì mettendo sullo stesso piano i tedeschi uccisi e quelli delle Fosse Ardeatine come vittime di uguale violenza. Questo, francamente, non è accettabile. Vi è forse l’idea che a Roma, che era la città santa sede del Papa, essendo città libera, non si dovesse fare nulla. La guerriglia urbana si fa con gli attentati. L’idea che si debba andare in divisa ad affrontare i tedeschi e i fascisti dopo tre squilli di tromba è palesemente assurda. Se si vuole la guerriglia urbana, si debbono mettere in conto anche gli attentati. Per quanto riguarda la rappresaglia, va tenuto conto che non sempre i tedeschi ne facevano di così terribili. A volte facevano rappresaglie, a volte no. Anzi si potrebbe perfino ipotizzare che ci fosse un calcolo deliberato da parte dei tedeschi. Il fatto di non sapere mai bene se ci sarebbe stata rappresaglia creava imbarazzo negli avversari. Se i partigiani avessero saputo che sempre e comunque per ogni tedesco ucciso sarebbero stati uccisi dieci civili, avrebbero avuto una norma precisa su cui
regolarsi. Invece così, nell’incertezza, si creava confusione e discussioni a non finire all’interno del Campo d’Agramante sull’opportunità o meno di certe azioni.
In un’intervista del dicembre 1987 sul «Corriere della Sera» Renzo De Felice ha invitato ad abrogare, perché “grottesche”, le disposizioni costituzionali che vietano la ricostituzione del “disciolto” partito fascista e, più in generale, a cancellare l’antitesi fascismo/antifascismo dalla identità repubblicana giacchè, ha precisato, “se resta ferma a quel dogma insincero, la nostra Costituzione si auto-inchioda”. De Felice giustifica questa sua proposta con il dibattito in corso sulla Grande Riforma istituzionale e sul passaggio a una Seconda Repubblica da molti auspicata in questi ultimi anni. Senza entrare nel merito delle riforme istituzionali (un discorso complesso che ci porterebbe molto lontano dal tema), mi sembra evidente che la rimozione del paradigma antifascista, quando anche avvenisse, non fornirebbe in alcun caso risposte funzionali all’attuale crisi degli ordinamenti. In questa diffusa voglia di disfarsi dell’antifascismo, a cui De Felice dà voce, sembra dunque celarsi qualcosa d’altro. Tu che cosa ne pensi?
Come è noto, De Felice e coloro che ne condividono sostanzialmente le posizioni, giudicano “insincero” l’antifascismo storico in quanto la presenza in esso del comunismo staliniano avrebbe reso improponibile l’equazione antifascismo = democrazia. A me sembra che il revisionismo storiografico di destra, di cui De Felice è il più autorevole rappresentante in Italia, si incontri con un “sentimento” abbastanza diffuso nel nostro paese che considera che il passato è ormai passato, e che comunque bisogna adoperarsi tutti perché sia definitivamente passato. Si vuole una sostanziale “pacificazione”. A questo si potrebbe rispondere che la pacificazione è già avvenuta, con l’amnistia Togliatti e altro, come pure c’è il rispetto per i caduti, o la comprensione per le vicende personali e i drammi familiari di chi era schierato con i fascisti (quando non fossero veri e propri criminali). In realtà chi parla di pacificazione oggi vuole rivalutare il ruolo politico svolto dalla RSI, e questo è inaccettabile. Io credo che conservare la memoria di ciò che è accaduto sia importante, anche per evitare di ripetere gli errori del passato. Noi dobbiamo ricordarci che l’Italia è stato un paese fascista. Una rimozione collettiva di questo fatto potrebbe essere pericolosa. In particolare credo che la norma della Costituzione che vieta la ricostituzione del partito fascista vada mantenuta. Se veramente la distinzione fra fascismo e antifascismo non avesse più senso, come da alcune parti si sostiene, allora si tratterebbe di una di quelle norme obsolete che cadono da sè senza bisogno di alcun atto ufficiale. Chiederne l’abolizione significa proprio – ed è un po’ paradossale – riproporre il problema della differenza tra fascismo e antifascismo, scatenando nuove polemiche. Ritengo quindi che sia un modo per reinserire nel gioco politico i fascisti di oggi. Tra l’altro, io sono per il mantenimento di quella norma anche per un problema di ordine pubblico. Certo si tratta di una ipocrisia (qualcuno però ha detto che “l’ipocrisia è un omaggio che il vizio rende alla virtù”), una norma colabrodo, ma a volte salvare certe forme ha un senso, e in questo caso evita l’esasperarsi dei contrasti. Pensiamo a che cosa accadrebbe se domani il MSI potesse chiamarsi Partito Fascista Repubblicano e cominciasse a fare delle sfilate con il ritratto del duce. Risorgerebbe sicuramente l’antifascismo militante, ci sarebbero scontri di piazza, tafferugli, qualcuno potrebbe ricominciare a sparare. Mantenere quella norma è quindi anche un atto di saggezza politica.
Di recente si è presentato sulla scena anche un “revisionismo di sinistra”, di cui è un esempio il pamphlet di Romolo Gobbi, Il mito della Resistenza (1992). Le tesi di Gobbi mi sembrano molto discutibili (Vittorio Foa ha definito il suo libro “spazzatura”) e non varrebbe forse neppure la pena di parlarne, se non fossero indicative di certi umori diffusi anche in settori minoritari della sinistra. Per alcuni gauchistes o operaisti la Resistenza è un fenomeno di scarsa rilevanza che ha poco a che fare con la classe operaia. La vera contrapposizione sarebbe sempre quella della lotta di classe tra proletariato e capitale, per cui il discrimine fascismo-antifascismo sarebbe fuorviante. Gobbi, in particolare, sostiene che gli scioperi nel marzo 1943 sarebbero stati motivati esclusivamente dalla fame e dal freddo, e che vi sarebbe stata una estraneità sostanziale della classe operaia rispetto alla politica dell’antifascismo. Qual è la tua opinione?
Io credo che per capire bisogna partire dall’operaismo. Gobbi (collaboratore in gioventù di «Quaderni rossi» e di «Classe operaia») è un post-operaista che prima ha collaborato e poi è entrato in lite con gli Istituti della Resistenza, quindi c’è anche un risentimento personale. Una ventina di anni fa, negli anni settanta, l’operaismo portò uno scossone salutare a una certa immagine oleografica e sciropposa della Resistenza. Poi però questo orientamento storiografico ha finito per isolare questo tema della classe operaia come se gli operai fossero una variabile indipendente della storia. Ciò che conta per gli operaisti è la purezza della classe in sè e questo mi sembra che non conduca molto lontano, sia teoricamente che proprio in base ai dati storici. L’operaismo è caduto in formulette ideologiche altrettanto aride e inconcludenti di quelle che voleva combattere. Le tendenze più dogmatiche dell’operaismo hanno finito per arrivare alla conclusione che della guerra civile fra fascisti e antifascisti, oltre che ovviamente di quella patriottica fra italiani e tedeschi, la classe operaia – la Classe – si era nella sostanza, e giustamente, disinteressata. Soprattutto mi sembra di somma ingenuità sostenere che gli scioperi del ‘43 erano dovuti solo alla fame e al freddo. Scioperare dopo vent’anni di fascismo, quale che sia il motivo che può spingere il singolo a scioperare, è un fatto di grande rilevanza politica. Significa, tra l’altro, non avere più paura della repressione. Inoltre, si sa che nel movimento c’erano alcuni dirigenti comunisti come Umberto Massola. Forse i comunisti in seguito hanno enfatizzato il loro ruolo al di là del lecito, ma sostenere che alla base dello sciopero c’erano solo motivi economici è veramente troppo riduttivo. In un contesto come quello, con il nemico in casa, con la popolazione infreddolita e affamata sotto i bombardamenti, la richiesta di un miglioramento materiale, negli scioperi di marzo, non poteva non caricarsi di un significato polemico contro il fascismo.
Nel suo libro Gobbi parla della Resistenza come di una leggenda, un’invenzione epica, un mito autoassolutorio di un’intera collettività che vuole liberarsi del senso di colpa per essere stata fascista e filonazista. Gobbi propone il superamento di quello che definisce il “mito della Resistenza”. Secondo lui gli italiani dovrebbero darsi una nuova base mitica, dovrebbero crearsi un nuovo e diverso mito di fondazione (che non si capisce bene quale potrebbe essere), e procedere a un cambio di regime e di classe politica dirigente (la Seconda Repubblica).
A me sembra che Gobbi voglia conquistarsi una fama dissacratoria a buon mercato, ma anzichè portare un contributo al rinnovamento degli studi rischia di fare regredire il dibattito. In questo modo il revisionismo di sinistra porta acqua al mulino del revisionismo di destra per delegittimare la Resistenza e distruggere il comune sentire che ancora tiene insieme il paese. Rischiano di essere demoliti i fondamenti morali della nostra convivenza civile.
Vorrei farti una domanda specifica sugli anarchici. Nel tuo libro quasi non compaiono, vengono citati poche volte. Eppure gli anarchici hanno dato un contributo notevole all’antifascismo per tutto il periodo tra le due guerre e sono stati presenti anche nella Resistenza, sia con formazioni proprie dove avevano la forza di agire autonomamente (Carrara, Milano), sia inseriti nelle formazioni “Garibaldi”, “Matteotti” e “GL” in altre località. Stupisce questa dimenticanza, anche in considerazione del fatto che nel tuo libro viene dato ampio spazio ad altri gruppi minoritari, compresi alcuni (trotzkisti, bordighisti, ecc.) il cui apporto alla Resistenza è stato sicuramente minore rispetto a quello degli anarchici.
Per la verità nel libro cito qualche giornale anarchico clandestino, a volte direttamente, altre volte riportandolo da altre fonti. Ammetto però di avere trascurato gli anarchici. Questa è una lacuna di cui sono pronto a fare ammenda. Forse è dipeso dal fatto che mi è sembrato che in fondo la loro partecipazione, da un punto di vista numerico, sia stata poco significativa rispetto alle forze maggiori in campo. Certo, però, fra i gruppi minori avrei potuto dare loro più spazio. Non c’era comunque in me alcuna prevenzione nei confronti degli anarchici. Tra l’altro, nel nostro gruppo del Partito Italiano del Lavoro, a Milano, c’era anche un anarchico che sarebbe poi divenuto abbastanza noto, Carlo Doglio.
Secondo te l’antifascismo è ancora un valore? È possibile una rinascita del fascismo?
Vorrei rifarmi a una frase di Capitini che cito anche nel mio libro: «“Antifascista” può diventare un giorno una parola inutile o molesta nel ricordo come “fascista”. Tranne un caso. Quello che i residui del fascismo ancora ricomparissero accanto o dentro i nuovi allineamenti politici». Ricordiamoci che il fascismo ha rappresentato una delle possibili grandi vie per risolvere i problemi della società di massa nel secolo che ormai sta morendo. Il fascismo è stato sconfitto, ma nei momenti di crisi di coloro che lo hanno vinto possono riaffiorare tentazioni di tipo fascista. Oggi, ad esempio, nella ex Jugoslavia assistiamo al ritorno sulla scena degli Ustascia e dei Cetnici. Non credo nella possibilità di un ritorno del fascismo nella forma tradizionale, quella di Hitler e Mussolini, ma sono sempre possibili soluzioni autoritarie e forme di nazionalismo esasperato. In un tale contesto, compito dell’antifascismo rimane quello di ricordare che esiste una tavola di valori irrinunziabili, che esistono valori fondanti a cui non si può rinunciare se si vuole continuare a vivere in un paese civile.
(a cura di) Gianpiero Landi, Sulla Resistenza: Intervista a Claudio Pavone (settembre 1992) in Quaderno n. 3 – Aprile 2021, Centro Studi Francesco Saverio Merlino