
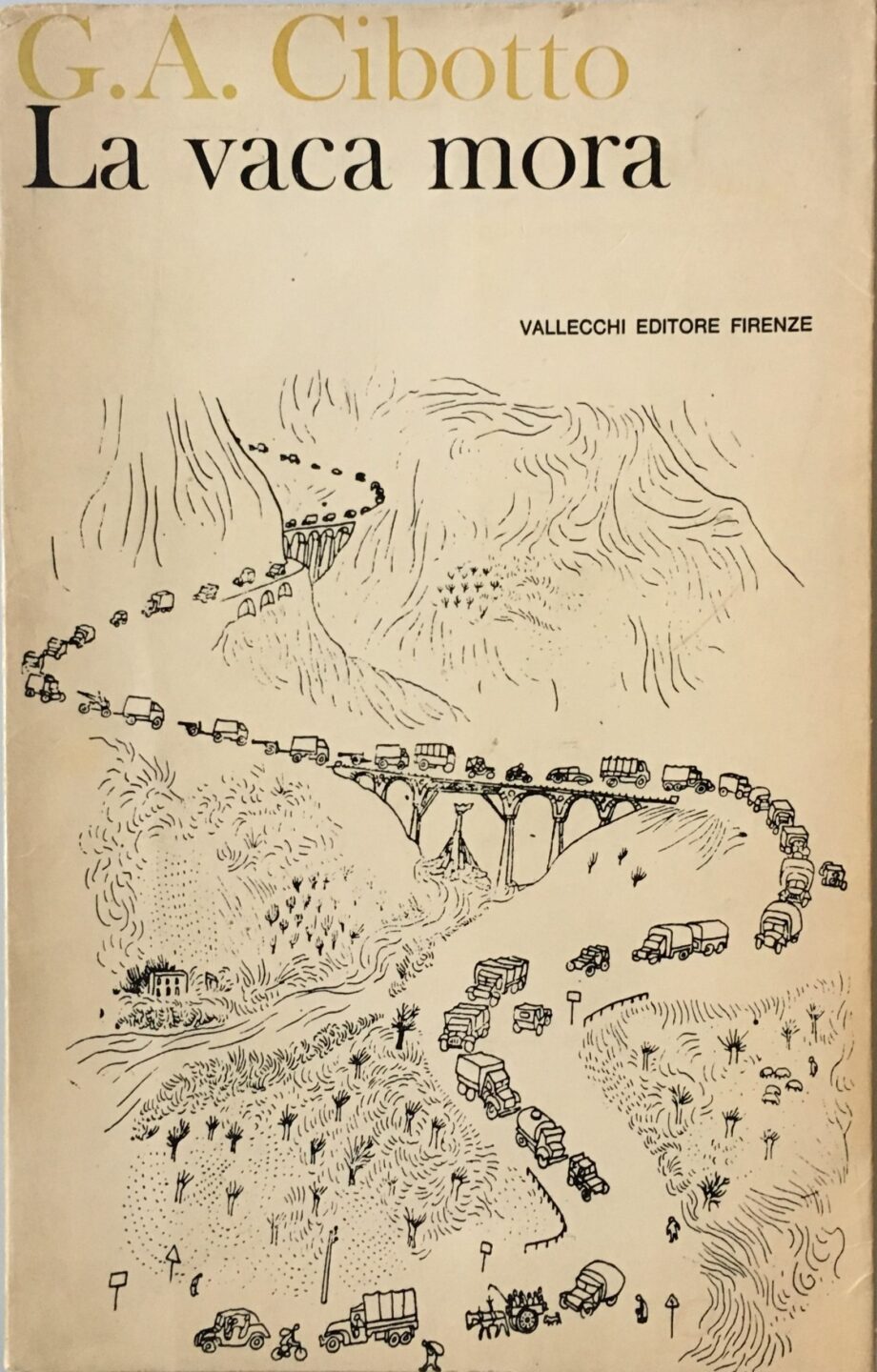
[…] Aveva un lato sorprendente, nel mio caso spiazzante. Alla fine degli anni ’90 decisi di inviare un mio racconto ad un concorso letterario, la giuria era presieduta da Gian Antonio Cibotto, niente di più allettante. Il racconto si intitolava Blu Cobalto, vicenda surreale che non venne presa in considerazione a scapito di altre storie. Decisi di scrivere una lettera provocatoria, direttamente al grande Cibotto. Archiviai la cosa come un esercizio di stile e sfogo autoreferenziale, ma una sera squillò il telefono di casa. Una voce profonda e decisa disse: “Buona sera sono Gian Antonio Cibotto, vorrei parlare con Elisabetta”.
Gian Antonio Cibotto, un signore
Mi stupisco ancora per quella telefonata che mi lasciò senza parole per qualche istante, ma dato che Elisabetta ero io, per educazione risposi. Voleva quasi scusarsi per non aver analizzato meglio il mio testo visionario e così da quella sera siamo diventati grandi amici. Gli raccontai che realizzavo programmi radiofonici alla Rai, e facevo fotografie, voleva vederle e mi venne a prendere alla stazione di Rovigo con la sua mitica Mini Minor e il bellissimo cane quasi più grande dell’automobile.
Passano gli anni
Qualche anno più tardi lo invitai ad una mia trasmissione televisiva, non ero più in RAI ma ad Antenna Tre, conduttrice di un talk di informazione e cultura “Ore 12” longevo quanto Porta a Porta. Sarebbe stato disponibile, lui lo era sempre, ma non si alzava mai prima di mezzogiorno. Eppure, una bella mattina del 1999, direttamente da Rovigo venne a Quinto di Treviso nei nostri studi, puntuale alle 12. Davvero straordinario! Come tutti i grandi non ha mai fatto pesare il suo strepitoso curriculum, scrittore, giornalista, critico letterario, tra gli ideatori del Premio Campiello uno degli eventi più prestigiosi. Appassionato di teatro, ha diretto per anni il Teatro Stabile del Veneto.
Gian Antonio Cibotto e il Campiello
Per il Campiello è stato Presidente di giuria nel 1972, segretario e componente di giuria in quasi tutte le edizioni a partire dal 1963 anno d’apertura, celebrata all’Isola di San Giorgio a Venezia. Vinse Primo Levi con La tregua. Il premio costituito dalla celebre vera da pozzo che si ispira iconograficamente al pozzo di San Trovaso, rappresenta il simbolo del campiello di goldoniana memoria, ma anche l’antico sistema di approvvigionamento idrico della città lagunare. Un premio di respiro internazionale voluto dagli Industriali del Veneto e che nel tempo ha segnalato il meglio della letteratura italiana.
I ricordi non si perdono mai
Nel cercare tra i miei ricordi di Cibotto qualche vecchia fotografia, ho sfogliato i suoi bei libri, Cronache dell’alluvione, Scano Boa, Veneto Segreto, In Paradiso con la Carrozza, Il principe stanco. Ho trovato anche una sua strepitosa autobiografia nella quale racconta come da giovanissimo lasciò Rovigo per andare a Roma “Dopo numerosi scontri con mio zio e mio padre che si ostinavano a volermi industriale”. Diventò in seguito caporedattore della “Fiera Letteraria” diretta in quel tempo dal poeta Vincenzo Cardarelli.
Il cappuccino
Ma c’è un appunto che mi piace tantissimo “Me ne andai a Roma, senza una lira, e per due anni cenai con una brioche e un cappuccino, perché non potevo permettermi di più. Questa abitudine infatti mi è rimasta, io mangerei sempre così”. Da storica golosa, sulla scelta del menù sono perfettamente d’accordo!
Elisabetta Pasquettin, Gian Antonio Cibotto e il suo cappuccino, èNordEst, 8 agosto 2020
[Gian Antonio Cibotto] Una delle più dolci sorprese di questa stagione letteraria che si annuncia piena di libri ma avara di opere valide, è venuta dalla tua nuova raccolta di poesie. Ci ho ritrovato il colpo d’ala dei momenti migliori e insieme una preoccupazione di sobrietà, scandita dal desiderio di aderire più intimamente alla realtà. Questo avvicinarti sempre più alle cose in una stagione in cui gli altri cominciano invece a distaccarsene, da che cosa deriva?
[Giorgio Caproni] Dagli anni. Potrei dire dall’approssimarsi della vecchiaia, se questo termine non avesse in Italia, un senso così dispregiativo. A cinquant’anni ci si può permettere il lusso, ci si deve permettere il lusso di ricapitolare, di riguardar la vita per sommi capi, nella sua giusta essenza, smorzando gli aloni e concentrando il fuoco. Si è giunti su un pianoro dal quale si può alfine scorgere intero almeno uno dei due versanti dell’esistenza nostra e quindi altrui. L’orizzonte delle esperienze (della ragione), a quota cinquanta è per forza più vasto che a quota venti: più vasto e più preciso. L’occhio, pagati tutti gli scotti, s’è illimpidito, s’è fatto più acuto e penetrante, riesce meglio a vedere in profondità, a distinguere le reali dimensioni di quelle che tu chiami «le cose», le cose che sono i fattori stessi della nostra vita, che sono la vita; riesce meglio a paragonarle fra loro, a raccogliere quelle essenze e a buttare tutto ciò che è posticcio, provvisorio, «fabbricato».
[Gian Antonio Cibotto] Se prendo in mano la raccolta dei tuoi primi versi «Come un’allegoria», che porta la data del 1936, oppure «Ballo a Fontanigorda», uscito due anni dopo, e li confronto con le tue raccolte più recenti, trovo che tua preoccupazione costante è sempre stata quella di superare certi residui sperimentalistici e intellettualistici (definiamoli così). Già con le famose «Stanze della funicolare », però, avevi raggiunto un tono sciolto e felice, fluido e disteso, nel quale le immagini respiravano in piena luce. Ora a leggere attentamente le tue ultime liriche si ha l’impressione che questo lavoro implacabile di scavo continui, che un’ombra di perplessità cali a intermittenza sul verso, quasi frenandolo. È un’impressione mia oppure colgo nel segno?
[Giorgio Caproni] Credo di non aver mai confuso il verbo «ricercare» col verbo «sperimentare», così come oggi lo si intende. Ogni artista, grande o piccolo, è in perenne ricerca d’una sua verità e d’un suo linguaggio. Lo sperimentalismo fine a se stesso è vuoto formalismo, prono conformismo a certe idee correnti che vorrebbero essere anticonformiste al massimo e che proprio per questa loro volontà (non necessità) obbediscono invece alla peggiore retorica del nostro secolo, il quale ha perso tanti dei suoi anni migliori (da quando ne aveva cinque ad oggi che si avvia alla settantina), a sembrare – perbacco! – «avanguardista», con tutto il corredo di pregiudizi, – spacciati con grande spreco di intelligenza ma con pochissime valide pezze di appoggio – che tale «idea» comporta. Quella certa perplessità che ti sembra talvolta di notare nei miei versi anche ultimi – quel «freno» – potrebbe appunto nascere dal continuo tremore ch’è in me di cedere al formalismo: di restare al di qua o di andare al di là della «cosa» (della verità che mi sono formata), lasciandomi trasportare dalla corrente dei puri giochi verbali.
[Gian Antonio Cibotto] Prima ancora di conoscerti, sapevo già di una fiaba che ti descrive nei panni di suonatore di violino, scaraventato nei posti più imprevedibili per suonare i motivi di moda. E poi nei panni più strani, in un crescendo di amarezza che però non t’impediva di coltivare in segreto la poesia. Alla tua esperienza di orchestrale devi qualcosa del tuo tono lirico che immerge il paesaggio e la memoria autobiografica in un alone di rara e musicale suggestione? Oppure si tratta d’una stagione dispersa che ami ignorare?
[Giorgio Caproni] Ti ringrazio di avermi offerto l’occasione di mettere in chiaro la «fiaba» cui accenni. […]
G.A. Cibotto, Caproni considera la critica una cattiva azione, “La Fiera letteraria”, 1 agosto 1965
Gian Antonio Cibotto (Rovigo, 1925-2017) si è sempre interessato di letteratura e teatro, alternando la narrativa alla saggistica. Dopo la laurea in giurisprudenza ha iniziato l’attività di giornalista e critico letterario e teatrale scrivendo per “il Resto del Carlino”, “Il Giornale d’Italia” e “Il Gazzettino”. Nelle sue opere ha sempre raccontato la sua terra natia, il Veneto, diventata una costante fin dall’esordio avvenuto nel 1954 con Cronache dell’alluvione. Della sua produzione successiva vanno ricordati: La coda del parroco (1958), Scano Boa (premio Latina, 1961), La vaca mora (premio Marzotto, 1964), Stramalora (premio Comisso e premio Napoli, 1982).
Ha diretto per anni il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e ha fatto parte della Giuria dei Letterati del premio Campiello, dalla prima edizione del 1963 fino al 1999. Con Cronache dell’alluvione La nave di Teseo inizia la ripubblicazione delle opere dell’autore in una nuova edizione.
Redazione, Gian Antonio Cibotto, La nave di Teseo

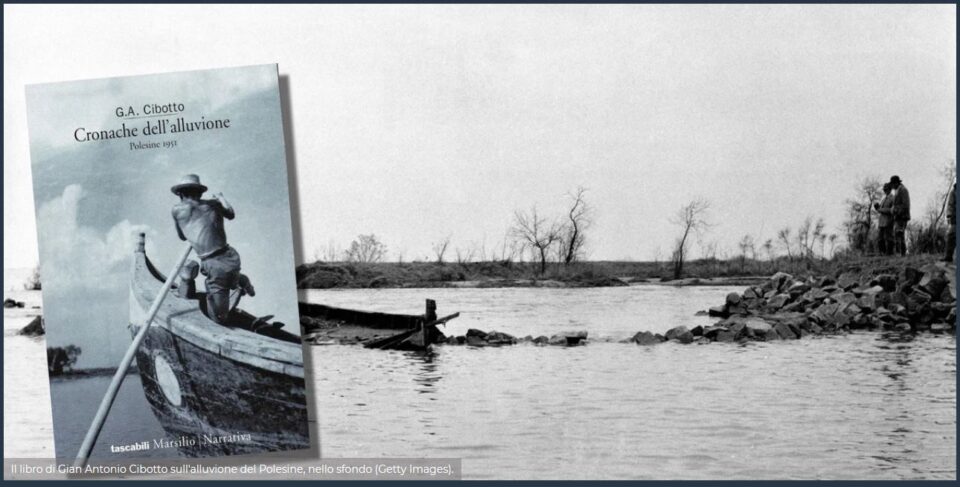
Lunatico e stravagante, contraddittorio e umorale, dice di lui chi l’ha conosciuto, cogliendo in questi tratti una irriducibile parentela con la gente della sua terra, i polesani “amanti del vino e delle strambe fantasie”. E la racconta in modo memorabile proprio quando è segnata dallo sconcerto e dal dolore; quando il 14 novembre 1951 “a Paviole, tra Canaro e Occhiobello, il Po rompe e si apre una breccia di duecento metri e oltre”. Centomila ettari di terra inondata, settant’anni fa esatti. Otto miliardi di metri cubi d’acqua.
Gian Antonio Cibotto detto Toni è lì, a cogliere l'”impressione tremenda” che fa il Po, una visione da incubo, l’incubo a occhi aperti in cui sei portato ad aggrapparti a pretesti illusori, assurdi per sperare di uscirne. Cibotto avanza sconvolto, incontra gente che armata di badili, sacchi di sabbia, paglia, fascine prova a difendere la valle dall’acqua. È straordinaria la capacità di cogliere la sospensione, l’apprensione, l’orizzonte di attesa che si incupisce. “Il senso del pericolo imminente. Lo scroscio dell’acqua è assordante, pauroso. Siamo ormai in vista dello squarcio. L’acqua entra con una velocità e un fragore di cascata, scaraventando ondate furiose contro l’argine, che si sgretola aprendo sempre più la bocca. Alle spalle il contadino ci urla che la terra sta cedendo e arretriamo di qualche passo”.
Appena tornate in libreria per La nave di Teseo, le Cronache dell’alluvione di Cibotto emanano ancora quella autenticità antiretorica che vi colse Montale alla pubblicazione, nel 1954. E dimostrano il potere emotivo di reportage in cui possibilità della scrittura giornalistica e possibilità della scrittura letteraria si fondono nella misura esatta: il giornalista come scrittore, verrebbe da dire nel caso di Cibotto, e insieme lo scrittore come giornalista.
D’altra parte, dopo la laurea in Legge a Padova, aveva cominciato a scrivere per quotidiani e riviste, cronache letterarie e teatrali (il palcoscenico fu una grande passione) per Il Resto del Carlino, Il Giornale d’Italia e Il Gazzettino. C’è il mestiere del cronista quando fa la spola per mezza giornata fra un ponte e la prefettura, c’è lo sguardo del narratore quando entra in una chiesa riparo di sfollati, “i ceri tremolanti nel fondo e l’atmosfera di mestizia generale, fa pensare a un enorme tomba di famiglia il giorno dei morti”. E c’è la sincerità dello scrittore quando racconta la propria stessa paura, e si chiede, a bordo di un’imbarcazione, all’alba, “che razza d’idea sia stata quella di venirmi a cacciare in un pasticcio del genere, mentre potrei essere tranquillo sotto le coperte. Le donne intanto cominciano a lamentarsi, e i bambini a strillare, perché hanno paura delle ondate che il vento ci scaraventa contro. Una vecchia prova a iniziare il rosario, ma le rispondono in due o tre, poi più nessuna. Sono paralizzate dallo spavento. A un nuovo urto che ci fa sbandare, alcune donne scoppiano istericamente in pianto, e i figli spaventati si agitano, mettendo in difficoltà quelli che remano”.
[…] Il paesaggio è quello in cui si muovono i personaggi di tutte le sue storie, i racconti aspri di La coda del parroco, in cui lampeggia lividamente anche la crudezza e crudeltà della mentalità “di paese”, e si esplora lo smarrimento nel passaggio dalla campagna alla città, fra estasi e perdizione. L’Italia del dopoguerra, stracciona, affaticata, speranzosa è al centro del romanzo La vaca mora, che nel titolo allude alla littorina Venezia-Mestre e fa a tutti gli effetti da convoglio di voci e storie, gente avvezza alle difficoltà del vivere, abituata a sopportare “con rassegnata fermezza i tiri della sorte”. Passano i camion degli americani, i soldati scendono ubriachi, ogni tanto l’ebbrezza e l’allegria e il desiderio sembrano una mano di vernice scintillante sulla polvere e sulle ferite della guerra, ma il presente resta avaro di promesse.
[…] Anti-libresco, schietto, intemperante. Pensava in veneto, dicevano di lui i suoi amici, e si specchiava di continuo nelle acque del Delta – là dove “spira sempre il vento e volteggiano rondini, garzette, gabbiani, aironi e farfalle… Seduto a riva, contemplo da una parte il mare d’erba e dall’altra l’immensa distesa d’acqua sulla quale respira il cielo. Insomma contemplo l’infinito, come non accade mai da nessuna parte”.
Paolo Di Paolo, Gian Antonio Cibotto. Del fiume Po e della sua furia, la Repubblica, 15 novembre 2021


[…] Gian Antonio Cibotto ne “La coda del parroco” raccontava un Polesine poetico: «Nelle notti estive, dalle mie parti le strade diventano canali, e rigano d’argento la malinconia della pianura».
Giambattista Marchetto, Dal Polesine a Pieve di Soligo: anima e luoghi degli scrittori veneti, Il Sole 24 Ore, 18 febbraio 2019

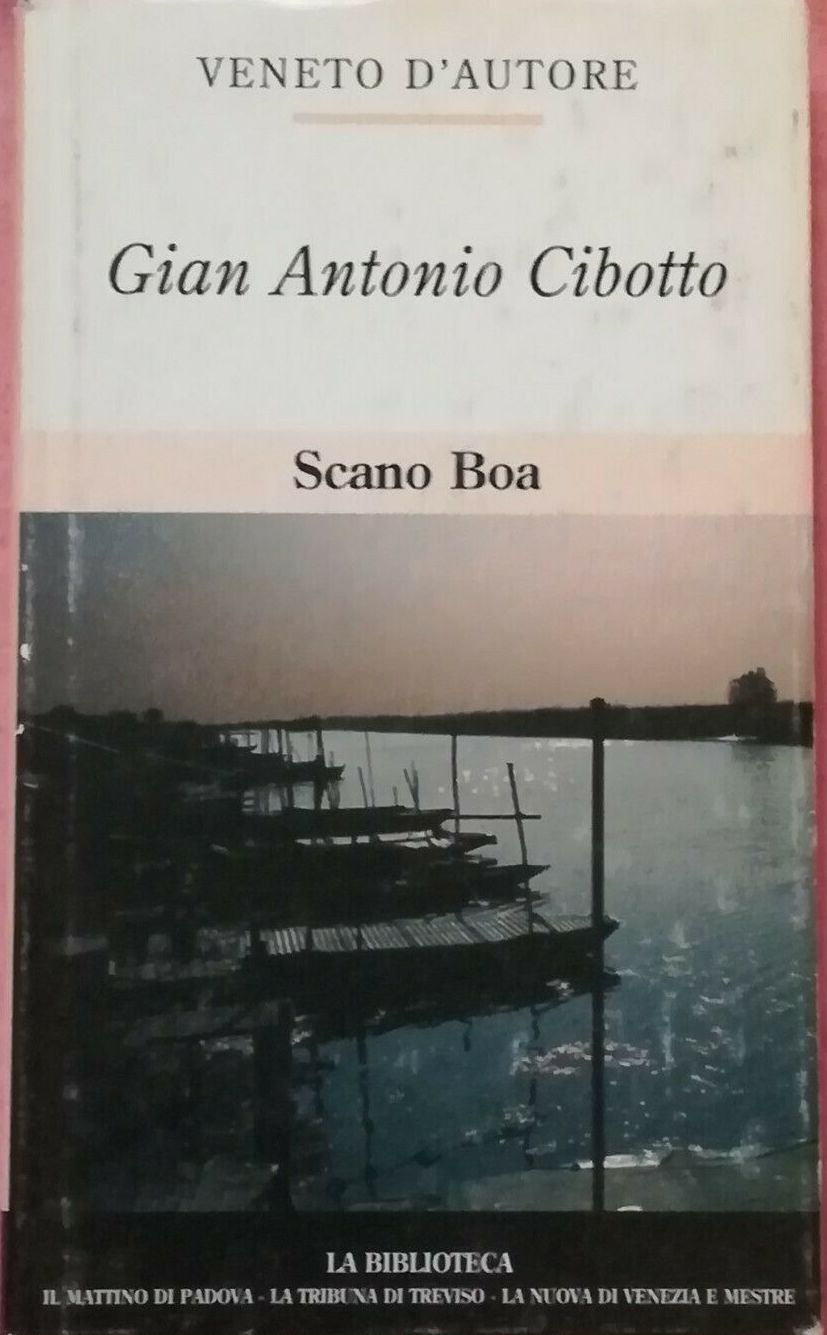

In realtà senza il Polesine e la sua gente Toni non avrebbe potuto scrivere. Lo dimostra la sua produzione, lo dimostra il rammarico, lo sdegno che fanno da contrappunto all’asciutta cronaca di quel 14 novembre e delle settimane che ne seguirono.
“Gente indocile la polesana, amara, di poche parole, sentenziosa e amante del vino e delle strambe fantasie; gente violenta, rissosa, eppure piena di abbandoni, capace di avarizie feroci e di squisite gentilezze, portata alla solitudine, ai pregiudizi, alle superstizioni, con individualità, come ha scritto Marchiori [Giuseppe Marchiori, critico d’arte e giornalista, nato a Lendinara nel 1902. n.d.r.], del tipo toccato dalla follia”
Nello scarno libretto l’immagine del fiume in rotta e che tutto divora e sommerge è resa con la partecipazione dell’esperienza, in presa diretta diremmo oggi.
“Incontriamo il Po. E’ così gonfio che tra la riva e il pelo dell’acqua ci sarà mezzo metro. Fa un’impressione tremenda… Le golene sono completamente sommerse. Fra i pioppi spunta ogni qual tratto gente che trascina le masserizie sulla strada… Oltrepassata la grande curva golenale, arriviamo in vista del fiume. Sembra il mare. Corre lento, gonfio, terroso, portandosi dietro migliaia di relitti che vengono a urtare contro la riva come trottole”
“Ore 20,30. E’ arrivata la notizia, portata non si sa da chi, che il Po ha rotto… Vedo frecciare la macchina del Gazzettino… mi informano che il Po ha rotto a Occhiobello e Paviole dove siamo diretti… Sfiliamo accanto a una litania di gemiti, lamenti, richiami, smarrimenti, invocazioni. Sono dovuti scappare così come si trovano…i più fortunati hanno potuto tirarsi dietro le bestie, che legate ai carri osservano pigramente il trambusto. Sembra di essere tornati indietro di qualche anno, ai giorni della guerra: lo stesso scappare disordinato, lo stesso guardare implorante.”
“Lo scroscio dell’acqua è assordante, pauroso. Siamo oramai in vista delle squarcio. L’acqua entra con una velocità e un fragore di cascata, scaraventando onde furiose contro l’argine, che si sgretola aprendo sempre più la bocca”.
A rendere incalzante il racconto non mancano episodi gustosi, descrizioni di caratteri, riflessioni morali, come questa: “.. nulla nella vita ci rende comprensivi e tolleranti come la coscienza della nostra debolezza, e nulla più feroci d’una debolezza che per timore fuori luogo, ci porta a considerarla uno stato d’inferiorità, da dissimulare. In fondo l’amore, il bisogno di confidenza, nasce dalla reciproca consapevolezza d’una inferiorità e dal bisogno di superarla aiutandoci con la mano di un’altra persona. L’egoismo invece da una inferiorità che ha paura di se stessa, e si giudica peccato, ombra morale, segno infamante”.
Né, lasciandosi per un attimo la tragedia alle spalle, mancano i momenti lirici: “ Lendinara, annunciata dalle agili ciminiere che s’incastrano di prepotenza tra la carovana di lunghe nuvole ingombranti il cielo, ci accoglie con la sua notturna dolcezza di paese scampato al disastro. Una dolcezza fatta di strade tranquille e deserte, di luci che si allargano timorose dai lampioni, di canti isolati che svaniscono in lontananza, di rumori sommessi sulla piazza sbiancata dalla luna, di vento odoroso d’erba, spinto a folate discontinue dall’Adige vicino”.
Le Cronache sono inframezzate di proverbi, un modo per l’autore per riportare al centro, con la loro saggezza popolare, i protagonisti di quei giorni.
Uno, in particolare, sembra riassumere paradossalmente tanto disastro e tanta sofferenza: “L’acqua e ‘l cuor fa morir in silenzio”. Il silenzio notturno, la case spettrali, le stalle vuote, la fila degli scampati composta e inerte. La vera disperazione, ci dice Cibotto, non gesticola, è muta, è impietrita. E i lamenti più dolorosi sono quelli delle bestie: “ Non ho mai sentito lamento più doloroso di quello delle bestie. Specie o buoi e i cani. Passando davanti alle stalle o alle case di campagna, udiamo continuamente il loro richiamo. Finisce con un rantolo sordo, strozzato, come un lamento senza speranza”.
Sfuggendo alle descrizioni neorealistiche, immergendosi nell’esperienza dell’alluvione col corpo e col cuore prima che con la mente, Toni Cibotto scrive un resoconto di straziante normalità, schietto e ancora oggi commovente, che apre più speranze di quelle che sembra volere abbandonare. E’ bene che Toni Cibotto abbia scelto di essere primo a Rovigo, piuttosto che ultimo a Roma. Se no non avremmo avuto il piacere di conoscerlo, nè avute le Cronache dell’alluvione, un piccolo classico minore che vale la pena rileggere, per ricordare un uomo serio e uno scrittore di razza.
Redazione, Toni Cibotto, Ninco Nanco…, 5 luglio 2018

Come i ragazzi di bottega dei quali si legge nella straordinaria “Carta del navigar pitoresco” di Boschini, che finalmente per la sollecitudine amorosa di una donna gentile, Anna Pallucchini, ha visto rispettata la sua musica inferiore, ricca di sfumature e di visioni, Carlo Maschietto ha lasciato la piana dolcissima, tagliata dalla lama stillante bagliori del Piave (anzi della Piave, dicono nel loro liquido dialetto i contadini, pieni di intuizioni folgoranti), per approdare in riva alla laguna.
Dove la favola della pittura continua a richiamare i personaggi più strani, che alle volte riescono ad imboccare sentieri inediti, lungo i quali tutto diventa nuovo, aderente al battito inquieto del sangue.
Nel breve arco d’una stagione ha preso confidenza con il mestiere, e facendo violenza alla sua naturale disposizione all’indugio contemplativo, che ogni tanto lo sorprende alle spalle, ha subito iniziato il suo apprendistato.
Scandito da una febbre sottile che lo ha portato a saggiare in tormentata progressione le varie tecniche legate a modi particolari, e talora viziati scopertamente di polemica, d’interpretare la realtà quotidiana.
Nel tentativo di affrontarla senza averne lo sgomento, di esorcizzarla in nome di valori che alla verifica del tempo, solito a bruciare con il suo lampo bianco lo schermo protettivo dell’illusione, finiscono immancabilmente con il perdere la loro rassicurante consistenza.
Per fortuna nei momenti in cui la tela diventava una specie di gorgo vorticoso in cui il pennello ripeteva ossessivamente un colore sempre uguale, quello della mancanza di scatto fantastico, Maschietto, non ha mai perduto fiducia nel lavoro, nello scambio attivo della scuola, nel gioco a sorpresa degli incontri, che l’aiutavano a cercare con una tenace, ostinata, disperata insistenza.
È stata un’esperienza logorante, che, proprio nella fase in cui la sua pittura accennava a diventare una sorta di geroglifico intellettualistico, lo ha visto bruscamente ripetere l’operazione auspicata da Pasolini nei suoi ultimi, accorati messaggi.
Nei quali proclamava che la salvezza s’identifica nel recupero d’una civiltà che, nonostante la pressione di un costume ormai prossima allo stravolgimento, riusciva a salvare il fiore della gentilezza umana, il patrimonio delle tradizioni antiche, la freschezza intatta del sentimento che non accetta di subire il degrado della mercificazione.
Con un coraggio che sorprende chi non ha dimestichezza con la sua scontrosa e gelosa intransigenza d’uomo abituato a guardare in faccia le cose, Maschietto ha ricominciato ab imis il suo itinerario creativo, andando alla riscoperta della sua gente e del suo paese.
Visto in una luce ferma e vibrante, che non indulge all’abbandono, ma sfocia nel racconto attraverso un sorvegliato e minuzioso accumulo di particolari.
Così implacabili da suggerire l’immagine d’un ossessivo rimorso, mentre al contrario, osservati con più lucido distacco, partecipano il senso esatto d’un processo liberatorio.
Nel quale gli alberi, l’acqua, le crete, le sponde, la vegetazione, l’erba, le barche diventano simboli d’un qualcosa che traluce dietro l’apparenza quotidiana.
Forse il segno di un’altra orbita, di montaliana memoria, in cui è possibile ancora la speranza.
Per la quale ogni sua tela rasenta la testimonianza.
Gian Antonio Cibotto, Lungo il fiume da San Donà di Piave a Noventa. Carlo Maschietto pittore, arte.go (tratto dal Catalogo: “Lungo il fiume da San Donà di Piave a Noventa. Carlo Maschietto pittore” – Edizioni Galleria del Naviglio – Milano, Direttore Renato Cardazzo, Catalogo stampato in occasione della 672a Mostra del Naviglio, 11-31 gennaio 1977)